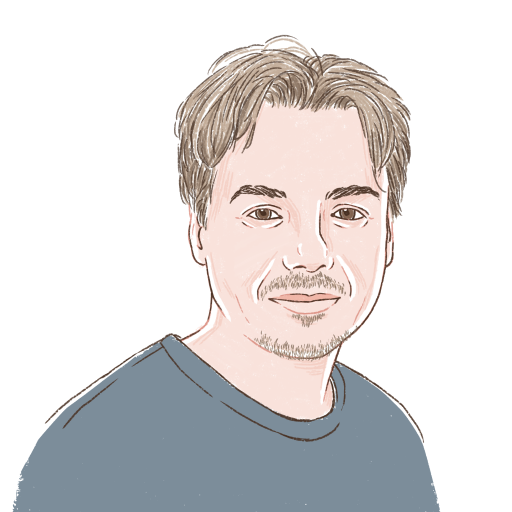Lo scorso 30 maggio Massimo Ruggeri è stato chiamato da Animazione Sociale ad intervenire, a nome del CNCA, nell’Agorà Adolescenti. L’incontro partiva dalla seguente provocazione: “se il malessere adulto fa cortocircuito con quello adolescente, la scuola cessa di essere ambiente educativo e di apprendimento”.
Di seguito riportiamo una sintesi della sua riflessione.
L’intervento di Massimo Ruggeri a “Agorà 2025: Adolescenti”
Anzitutto credo sia utile non dare per scontato che tutti pensino alla scuola come un ambiente educativo (mi pare, ad esempio, che il Ministro dell’Istruzione e del Merito abbia un’idea diversa).
Ho la sensazione che la questione sia ontologica (dobbiamo chiederci i “perché” più che i “come”) e che sia strettamente connessa a quel cortocircuito tra il malessere degli adolescenti e quello degli adulti.
Pur con tutte le differenze che ci spingono a parlare di adolescenze al plurale, stiamo osservando una situazione di aumento e di complessificazione della sofferenza (che gli adolescenti esprimono sussurrando, gridando, stando in silenzio…).
Eppure questa sofferenza riguarda anche gli adulti: agiti violenti, manifestazioni d’odio, crisi di panico, burnout… sono dimensioni che ci coinvolgo direttamente, rispetto alle quali quale non siamo più osservatori neutri.
Quella che stiamo vivendo è una crisi di prospettiva: è come se ci stessimo dicendo che non è questa la vita che vogliamo vivere e al tempo stesso non fossimo capaci di desiderare un futuro diverso.
Lo ha sintetizzato molto bene uno studente di 18 anni:
“Ci dicono sempre che si stava meglio un tempo e che nulla è più come prima. Ma se davvero è così, noi giovani abbiamo già perso in partenza; per noi non c’è partita”.
È quella che possiamo definire “narrazione della catastrofe”. Ed è strettamente connessa con le poli-crisi che attraversano questo nostro tempo.
Una crisi di prospettiva
Questa crisi di prospettiva ruota attorno a due questioni chiave.
La prima ha a che fare con una società prestazionale, iper-competitiva ed estrattiva. È un modello che si basa sull’idea di fondo che le risorse siano illimitate. “No limits” e “Impossible is nothing” sono slogan che rendono bene l’idea. Ma restano slogan: le risorse sono scarse per definizione e i limiti esistono e ci definiscono. Questo modello da un lato sta rendendo sempre più pervasiva la competizione, dall’altro sta provocando un’accelerazione che sentiamo non essere più sostenibile: abbiamo la sensazione di essere su un gigantesco tapis roulant dove corriamo sempre più veloci per rimanere fermi sul posto…
La seconda è connessa all’iper-Individualismo che caratterizza questa fase storica (lo slogan thatcheriano “la società non esiste, esistono solo gli individui”). Un individualismo che ha sfaldato le reti relazionali, ci ha illuso che potessimo avere il controllo ma poi ci ha lasciato profondamente soli e impotenti.
Lo ha descritto molto bene Franco Arminio:
“Dall’America ci dicono che la solitudine è un’epidemia e uccide come uccide il fumo. Si sono accorti che troppa gente vive in solitudine, che il diritto a costruirsi la propria vita senza badare più di tanto a quella degli altri è diventato un dolore, il dolore di mettere acqua in un secchio rotto, di andare a dormire con la testa affollata di parole e con il cuore vuoto.”
Immaginare un futuro desiderabile insieme.
Abbiamo bisogno di tornare ad immaginare insieme un futuro che sia desiderabile. Coltivare nel presente un futuro desiderabile vuol dire aprire alle prospettive divergenti, ibridare sguardi, competenze, pratiche, alfabeti… Qui credo stia un primo ribaltamento di paradigma: il senso della relazione tra adulti e adolescenti.
Più delle altre fasce d’età i giovani vivono proiettati nel futuro e quindi percepiscono la lacerazione del presente. Rileggere il grido degli adolescenti come un avvertimento non significa minimizzarne la portata ma promuoverne la corresponsabilità nell‘immaginare un futuro che vada oltre la narrazione della catastrofe.
Ragazze e ragazzi raccontano già nel presente altri modi possibili di abitare il mondo: il diritto a stare male, il rifiuto della competizione come forma predominante di interazione tra le persone, la centralità del tempo liberato, il bisogno di prossimità fisica ai viventi delle altre specie, la possibilità di manifestare il dissenso con l’assenza e il silenzio… sono solo alcune delle nuove forme che stiamo imparando a conoscere.
Mettere in atto il cambiamento
Ritorno allora alla questione ontologica che citavo in apertura. Siamo alle soglie di una nuova rivoluzione copernicana: stiamo percependo che non siamo soli al mondo, che tutto è intrecciato: gli umani, gli animali, le piante. Oggi percepiamo solo indistintamente le potenzialità di questa nuova prospettiva, ma alcuni elementi possiamo già provare a coniugarli, mi soffermo su tre parole chiave:
- Cura: prendersi cura dei luoghi e delle relazioni. Il deserto di Atacama è uno dei luoghi inospitali. Eppure periodicamente fiorisce, e i suoi colori sono una delle meraviglie del pianeta. Quanto siamo capaci di guardare al deserto come luogo della fioritura? Siamo capaci di praticare sconfinamenti e mettere al centro l’incontro, la relazione?
- Collaborazione. Come ci ricorda Benasayag, pensare è un atto incarnato, emergente, relazionale: il cervello isolato non produce pensiero. Serve un soggetto vivente, situato, che abiti un mondo e che ne venga trasformato. Quanto i nostri setting sono relazionali (cooperativi e non competitivi) e situati? Quanto il rapporto con l’ambiente circostante influenza i contesti di apprendimento? Quanto il gruppo è luogo di produzione di un sapere esperienziale?
- Passione. Viviamo in un tempo che ha prodotto l’industrializzazione della paura: la paura “vende” ma ci fa vivere peggio. Più potente della paura è la passione: ha una grande forza generativa ed è relazionale, non individuale: quanto i nostri setting di apprendimento permettono di scoprire e coltivare passioni?
Chiudo ricordando Franco Basaglia: ha saputo cambiare la realtà immaginando ciò che non esisteva, collaborando e restituendo potere, abbattendo muri che sembravano indistruttibili. Raccontando quell’esperienza ha scritto: “abbiamo dimostrato che l’impossibile può diventare possibile”.
Penso sia il migliore augurio che possiamo fare a tutti noi!